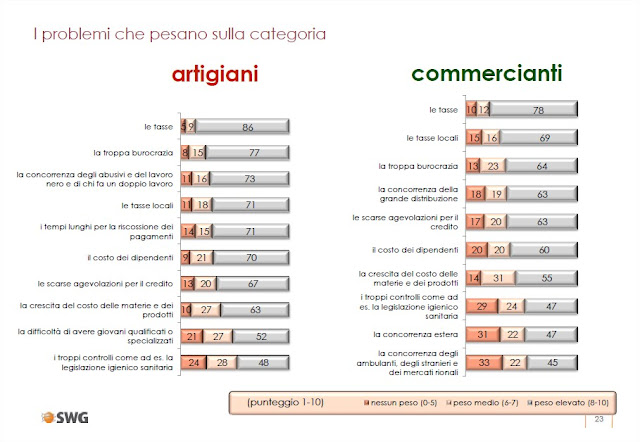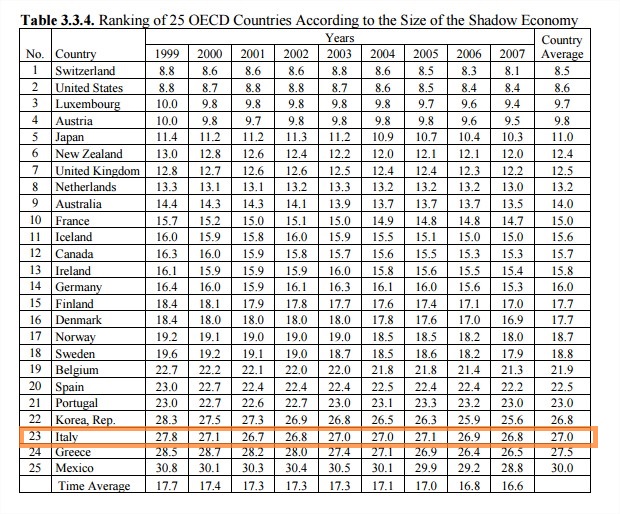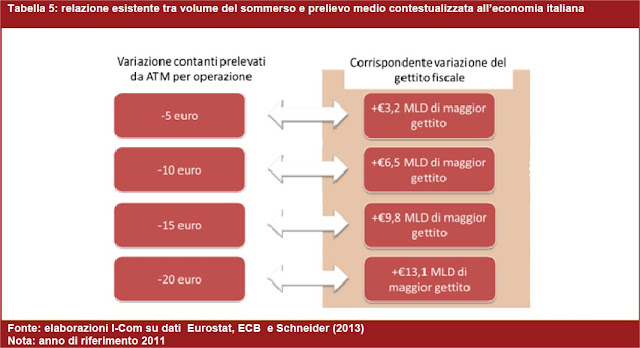Nonostante la bramosia della
costruzione di un pensiero uniforme a livello di società sia insita in
qualsiasi struttura di potere, la sistematicità con cui l’attuale esecutivo
coltiva l’ossessione del controllo sul dissenso merita una discussione più
approfondita per capire quale forma di Paese sta venendo brutalmente plasmata.
Dal governo, ovviamente, ma anche dai suoi mentori assiepati nei consigli di
amministrazione o nell’assortita serie di think-tank capillarmente concentrata
nel mantenimento dell’egemonia culturale dei dogmi neoliberali – dall’Adam
Smith Institute alla Heritage Foundation, dalla Société Mont-Pelerin all’Istituto
Aspen, dalle Bildeberg Conferences alla Tavola Rotonda degli Industriali
Europei.
Un ricco vivaio a cui da un lato
la cospicuità dei mezzi finanziari e dall’altro la pigrizia della controparte
nel tentare una risposta specularmente vivace (attualmente le uniche riviste di
pensiero critico di discreta diffusione sono le anglosassoni «Monthly Review» e
«New Left Review») ha concesso dapprima il controllo dell’informazione di massa,
poi il quasi monopolio delle istituzioni politiche. Manca solo qualche tassello
per raggiungere il pieno controllo sociale; anzi, provvede l’ormai celebre
Report dell’imponente società finanziaria JP Morgan «The Euro Area Adjustment: About Halfway There» (Europe Economic Research, 28/05/2013) a fare il punto della situazione: dopo che il titolo riconosce la diligenza
nell’aver svolto circa la metà del percorso auspicato, dal nono punto in poi dell’elaborato
s’indica con chiarezza alle nazioni dell’eurozona la prossima tappa da
completare:
risolvere l’inadeguatezza delle Costituzioni «nate troppo a ridosso della
sconfitta delle dittature», ritenute eccessivamente infettate da «una forte
influenza socialista» e inclini ad affermare «governi deboli», evidentemente
non forti abbastanza per debellare con disinvoltura «la protezione
costituzionale dei diritti al lavoro» e soprattutto l’impiccio più ostico di tutti,
«il diritto di protestare quando intervengono modifiche sfavorevoli dello
status quo» (pag.12).
 |
| La grande banca invoca la rimozione dei principi costituzionali, la politica esegue con entusiasmo |
In maniera meno sbrigativa, un
rapporto dello scorso anno della fondazione Italiadecide («Italiadecide, Rapporto 2014. Il Grand Tour del XXI Secolo: l’Italia e i suoi territori»,
Società Editrice il Mulino)
lautamente foraggiato dai capitali di Benetton e Intesa Sanpaolo arrivava ad
analogo auspicio: usando il pretesto molto gettonato del rispetto verso il
turista, si afferma a pag.239 che l’afflusso turistico è determinato in misura
consistente
«dall’immagine fornita dal sistema paese, dalla sua credibilità,
dal senso di sicurezza trasmesso ai potenziali visitatori, dall’idea di ordine
e di organizzazione territoriale, sociale ed economica veicolata dai
mass-media, dalle cronache quotidiane, dai social network».
Grazie a poche parole si palesa
insomma l’obiettivo di ottenere un pensiero unico totalizzante, di cui un
passaggio straordinario – dalla crisi economica all’organizzazione di un grande
evento come l’Expo – può rappresentare il catalizzatore ideale per anticiparne
gli aspetti di maggior portata.
Non sorprende quindi che la
classe capitalistica transnazionale abbia plasmato nel laboratorio dei media un
Presidente del Consiglio come Matteo Renzi, la cui cifra e carburante del
successo sono fondati su uno spavaldo disprezzo nei confronti del pensiero ponderato analogo a quello del pietoso filosofo Callicle, celebre per diffondere nell’Atene
classica il ripudio canzonatorio verso la razionalità: «La filosofia è un’amabile
cosa, purché uno vi si dedichi, con misura, in giovane età;
ma se uno vi passi
più tempo del dovuto, allora essa diventa rovina degli uomini» dichiarava nel «Gorgia»,
giungendo alla sincera conclusione che in fin dei conti le regole – comprese quelle
democratiche – sono arzigogoli inventati da «uomini deboli e del volgo», futili
orpelli per «i ben dotati dalla natura» meritevoli di agire «e di prevaricare»
secondo la loro indole. Il sociologo Marco Revelli, che con sagacia ha per primo
notato questa somiglianza, nel suo ultimo libro arriva all’amara considerazione
che
 |
| Il sociologo Marco Revelli |
«ogni volta che il nostro paese
riscopre il fascino cupo del carisma come extrema ratio, è lì che ritorna, alla
velocità della luce: a quell’archetipo tossico che contrappone l’azione al
pensiero. Il demiurgo al riflessivo. Il fare al pensare. E addita nell’intellettuale
il nemico della Patria. Il podagroso posapiano che rallenta gli arditi. L’ostacolo
al radioso futuro che il piè veloce Achille promette e manterrà» (da M. Revelli, «Dentro e Contro: Quando il populismo è di governo», i Robinson/Letture, Editori Laterza, ottobre 2015, pos.947 della versione Kindle).
L’attacco che fin dalle prime settimane
di azione i principali componenti dell’esecutivo hanno riservato alle maggiori istituzioni della formazione del pensiero non lascia spazio a dubbi sulla
rilevanza che questo aspetto ricopre nell’azione di governo: già il 31 marzo
2014 il Presidente del Consiglio sulle colonne del «Corriere della Sera»
scherniva la categoria dei «professoroni» e dei «professionisti dell’appello»
(dall’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo, «“No, il Senato non sarà più elettivo”») facendo da apripista alle frecciate che appena qualche giorno più tardi Maria
Elena Boschi riservò contro «le continue prese di posizione dei professori»
colpevoli «negli ultimi trent’anni» di aver «bloccato un processo di riforma
che invece non è più rinviabile» (dichiarazioni rilasciate nella trasmissione «Agorà», su Rai 3 del 04/04/2014).
 |
| Il premier Matteo Renzi |
Una chiara insofferenza verso il
pensiero critico che accompagnerà gran parte degli ultimi interventi
legislativi, tutti accomunati dal filo conduttore di costruire una società
fondata sul dominio incontrastabile della prevaricazione aziendalistica (dopo l’approvazione
dello squallido
Jobs Act, Renzi si gongolò all’assemblea generale delle
Confindustrie europee di aver debellato «il rischio di un giudizio» verso le
imprese) il cui acme è stato raggiunto nell’imperio della «buona scuola»,
barbaro tentativo di assoggettare definitivamente l’istruzione pubblica ai
canoni dell’impresa (tramite partenariato pubblico-privato, indicatori di
risultato, agenzie di controllo, autonomia e sanzione immediata dei dipendenti
incapaci) al fine di formare cittadini a cui l’accumulazione finanziaria
risulti non la migliore tra le situazioni possibili, ma l’unica situazione
concepibile. La capacità di «esplorare la possibilità di salvezza tramite la
facoltà di distinguere» (da J. Birkmeyer, «Kritische Bildung perdu? Einsprüche gegen das neoliberale Hochschulklima»), ossia il non lasciarsi sopraffare dall’astuto trucco propagandistico del «non
ci sono alternative» è l’arma più temuta dagli assetti di potere, adoperarla è
il mezzo migliore per intralciarne l’interessato percorso.