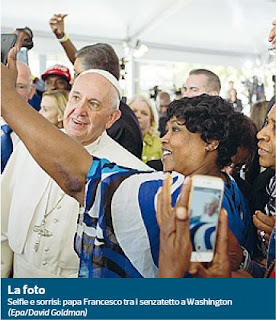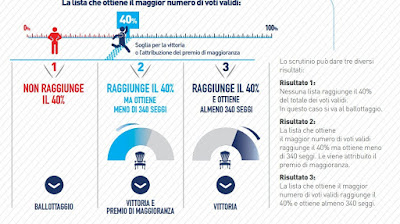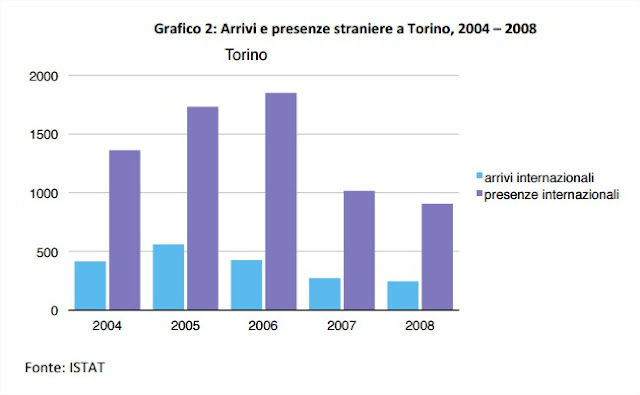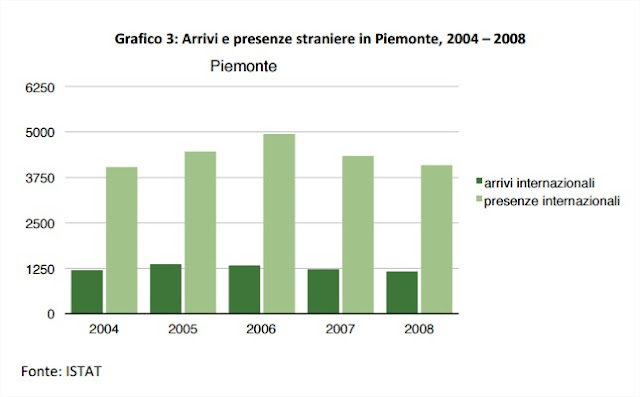Nel 1642 alcune colonie dell’America
settentrionale, capofila la Virginia, emanavano una legge che vietava il culto
del cattolicesimo, ne perseguitava i sacerdoti e interdiva ai fedeli qualsiasi
ruolo nell’amministrazione pubblica; nel momento in cui queste colonie decisero
di unirsi e rendersi indipendenti tra le prime azioni ci fu quella d’inserire
nel Primo emendamento della Costituzione il divieto di qualsiasi ingerenza
religiosa nella pratica politica. Una regola valida per il puritanesimo, la
fede più diffusa tra gli statunitensi dell’epoca, ma soprattutto per un
cattolicesimo il cui coinvolgimento nelle tremende guerre di religione interne
all’Europa aveva suscitato un profondo trauma tra i legislatori del nuovo
stato.
 |
| Lavoratori del Congresso usano l'effigie "obamizzata" di Papa Francesco nel corso di una manifestazione a favore del salario minimo |
Ciononostante l’ostilità, ricambiata,
verso la minoranza cattolica era ben lungi dal trovare un punto di pacificazione,
e alla discriminazione spesso sconfinata in colluttazioni violente si andarono
ad aggiungere nel corso dei decenni sempre nuove vertenze in cui Santa Sede e
Stati Uniti si trovavano su versanti opposti: dalla natura libertaria delle
istituzioni d’Oltreoceano (a fine
Non ci si sorprenda, dunque, se
durante la seconda guerra mondiale vennero divulgati volantini e vignette (la
cui eco venne tramandata arrivando perfino alle elezioni presidenziali del
1960) in cui i cattolici americani erano rappresentati come infiltrati
destabilizzanti al soldo di una rivale potenza straniera la quale, perfino nel
corso della lotta anti-nazista, non mancò di polemizzare con gli Stati Uniti
per l’alleanza strategica coi sovietici.
Il dissapore era talmente
incancrenito che nemmeno la comune ferocia nella disputa anti-comunista riuscì
a compattare le due autorità; anzi, Papa Pio XII non mancava di rimarcare
quanto il
materialismo tipico della società statunitense fosse deleterio tanto
quanto quello della società russa e uno degli sporadici candidati alla
presidenza Usa di fede cattolica fu costretto nel 1960 ad una solenne
dichiarazione pubblica in cui giurò che nel caso di elezione non si sarebbe mai
piegato ai diktat della Santa Sede. A mantenere intatto il solco arrivarono nel
corso del tempo la guerra in Việt Nam, l’Ostpolitik vaticana, il commercio di
armi, le guerre del Golfo, l’immigrazione, la pena capitale, l’istruzione e,
naturalmente, i temi etici.
«Insomma», conclude Manlio
Graziano (docente di Geopolitica delle religioni all’Università Paris IV e all’American
Graduate School di Parigi), «gli Stati Uniti e la Santa Sede si sono trovati
molto raramente a percorrere la stessa strada; e quando hanno condiviso gli
stessi nemici, la lotta contro di essi non perseguiva gli stessi scopi»;
il che è avvenuto fino a pochi
anni fa se si considera che ancora nel 1984 i tentativi di accordi diplomatici
fra Washington e il Vaticano suscitarono aspre polemiche.
 |
| Da "Limes-rivista italiana di geopolitica", n.4/2015 |
Eppure nel corso degli ultimi
anni qualcosa sembra essere cambiato: se per i funerali di Papa Paolo VI nel
1978 la delegazione statunitense era composta unicamente dalla madre del
presidente Carter, per quelli di Giovanni Paolo II nel 2005 accorsero il presidente
George W. Bush, il padre (nonché ex-presidente) George H.W. Bush, il
predecessore Bill Clinton, il segretario di Stato Condoleeza Rice e un
prestigioso assortimento di delegati non ufficiali come Edward Kennedy, John
Kerry, George Pataki, Micheal Bloomberg, il capo dello staff della Casa Bianca
Andrew Card e il leader repubblicano al Senato Bill Frist. Un riconoscimento
per il ruolo svolto da Papa Wojtyła nella caduta del regime comunista? Può
darsi, ma da solo non riuscirebbe a spiegare la formidabile escalation di
cattolici nelle leve di comando degli Stati Uniti che vede nell’amministrazione
Obama un apice talmente smaccato da essere ritenuto da molti un unicum
destinato a non ripetersi.
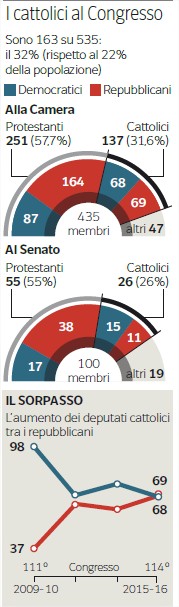 |
| Dal "Corriere della Sera" del 25/09/2015 |
Il caso più lampante è quello
della Corte suprema, ove attualmente sei giudici su nove sono di fede cattolica
(non dimentichiamo che nella sua secolare storia solo tredici cattolici sono
riusciti ad accedervi, e sei di questi siedono contemporaneamente ai giorni
attuali). Ma devoti alle gerarchie vaticane risultano anche ambedue i consiglieri
per la Sicurezza interna, il vice-presidente, il capo dello staff della Casa
Bianca, fino a qualche giorno fa entrambi i presidenti della Camera dei
deputati (il repubblicano John Boehner si è dimesso proprio per l’emozione seguita
all’intervento di Papa Francesco al Congresso), il leader democratico della
Camera, il direttore dell’Fbi, il vicedirettore dell’Fbi, il direttore della
Cia, il comandante dei marines, entrambi i capi di Stato maggiore scelti da Obama,
il capo di Stato maggiore dell’Aviazione e il consigliere del periodo 2010-2013
per la Sicurezza nazionale. Cattolici, inoltre, risultano quasi il 40% dei
governatori e all’incirca la metà degli aspiranti candidati alla Casa Bianca
per la corsa del 2016 (da Jeb Bush a Joe Biden, da Marco Rubio a Andrew Cuomo,
da Bobby Jindal a Joe Manchin).
In rapporto con la percentuale di
cattolici negli Usa (tra il 25 e il 30%) il ruolo dei cattolici nelle cariche
scelte direttamente dal presidente risulta davvero sbalorditivo (cosa che non
avviene per i membri cattolici del Congresso i quali, essendo non più del 31%,
rispecchiano in maniera accettabile il contesto sociale) al punto tale che è
difficile non scorgere una precisa volontà della Casa Bianca di attorniarsi di
adepti di questa fede.
Visto che l’autentico nodo del
contendere che ha separato Washington dal Vaticano nel corso dei secoli- ossia
il timore che l’uno scavalcasse l’altro nel dominio dell'egemonia morale (e di
mandato divino) nel pianeta- non è davvero mai stato sciolto, diventa assai intrigante
capire i motivi di questa scelta: di certo non il calcolo elettorale visto che
i cattolici raramente si sono schierati compattamente per uno schieramento (per
quanto bisogna riconoscere che ambedue le convention dei partiti per le
elezioni del 2012 furono chiuse dall’intervento dell’arcivescovo di New York
Timothy Dolan), forse il desiderio di non inimicarsi un alleato prezioso (anche
in vista del suo ruolo diplomatico), forse la preparazione più adeguata dei
militanti cattolici, forse la posizione sociale privilegiata che i cattolici
hanno mediamente acquisito dal termine della seconda guerra mondiale (all’inizio
del Novecento la Santa Sede temeva la presenza di devoti troppo maturi e
consapevoli), forse il semplice aumento dei cattolici nel paese (alcuni
studiosi arrivano a prevedere una crescita poderosa causata dall’immigrazione
sudamericana, per quanto la maggioranza degli immigrati ispanici non si
dichiari cattolico) ma forse anche qualcosa di più, che risale a un sentimento
più profondo dell’animo americano.
La catastrofe dell’11 settembre e
la travolgente crisi del settore creditizio hanno svegliato il popolo
statunitense dal sogno di un pianeta ove dominano incontrastati una pace e un
ordine assicurati dalla forza politica ed economica degli Usa. L’America nel
giro di pochi anni si è scoperta fragile, vulnerabile, agevolmente
contrastabile da altre potenze globali e di conseguenza
affamata di solidi
punti di riferimento a cui aggrapparsi. La Chiesa in questo senso ha svolto un
ruolo letteralmente provvidenziale, avendo dalla sua parte non solo una
secolare tradizione, ma anche un’autorevolezza inattaccabile per milioni di
fedeli, un saldo radicamento e una compattezza ammirevole (cosa che, ad
esempio, gli evangelici non dispongono) che proprio per questo arriva a
costituire- specie in periodi di crescenti attacchi ai servizi essenziali- uno
dei pochi sistemi di protezione sociale.
Non ci sorprenda, quindi, se
dagli inizi degli Settanta ad oggi si è registrata proprio negli Usa una
crescita di diaconi permanenti che non conosce eguali (tra il 1995 e il 2005,
nonostante tutti gli scandali e le vicissitudini della Santa Sede, il loro
numero è raddoppiato) a cui va abbinata la presenza del 12,5% dei sacerdoti presenti
nel mondo (a fronte del fatto che negli Usa è presente solo il 7% della
popolazione cattolica globale) e un rapporto tra preti e popolazione quadruplo
rispetto all’Africa, quasi nove volte superiore a quello asiatico e superiore
perfino nel contesto del continente americano.
Non ci si faccia troppo
suggestionare, quindi, dai dati pur indicativi sulle crisi delle vocazioni
sacerdotali: la fede cattolica in America non vive momenti di crisi,
semplicemente la sua base confessionale è divenuta più consapevole e dinamica,
al punto che lo stesso Papa Francesco ha dovuto riconoscere che
«veniamo da una
pratica pastorale secolare in cui la Chiesa era l’unico referente della
cultura. […] Ma non siamo più in quell’epoca. È passata. Non siamo nella
cristianità, non più. Oggi non siamo più gli unici che producono cultura, né i
primi, né i più ascoltati» (si veda l’udienza ai partecipanti al Congresso internazionale della pastorale delle grandi città, 27/11/2014).
 |
| Da "Limes-rivista italiana di geopolitica", n.4/2015 |
Forse solo gli Stati Uniti degli
ultimi anni paiono andare sorprendentemente in controtendenza, e se un Papa ha
varcato per la prima volta la porta del Campidoglio non è da escludere che fra
qualche mese un cattolico varcherà le porte della Casa Bianca.